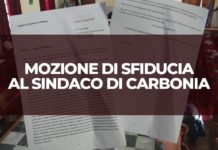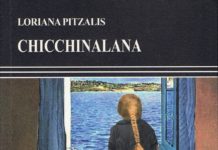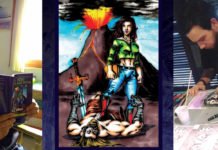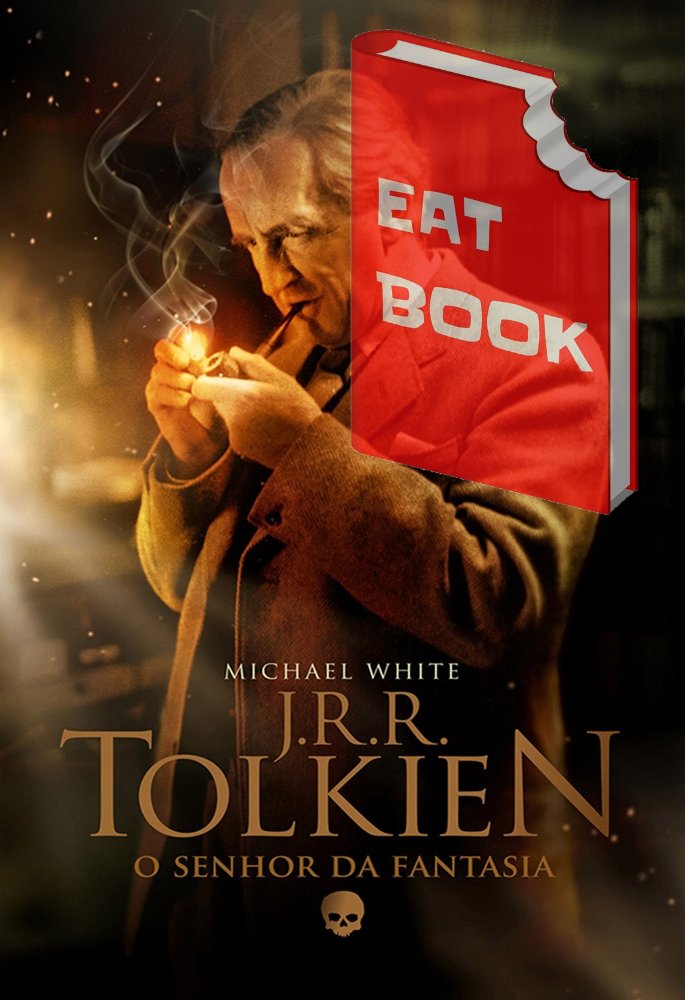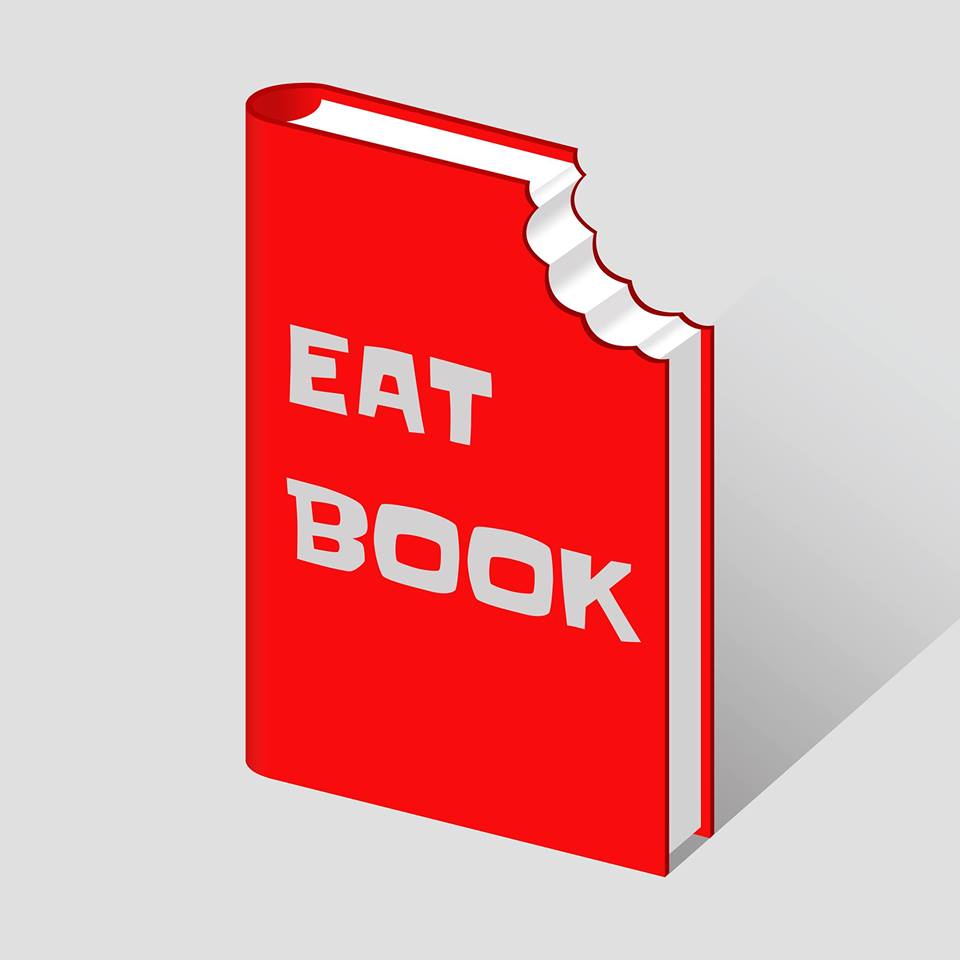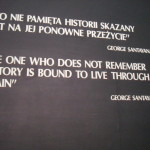Vivevo il mio Erasmus da qualche mese quando, insieme ad altri compagni di avventura, decidemmo di visitare Auschwitz.
Cracovia distava soltanto una notte in treno e una trattativa notturna col controllore polacco sul costo in euro del biglietto. A soli 50 km da Cracovia, si trova la cittadina Oświęcim, meglio nota col nome tedesco Auschwitz, nelle cui vicinanze è situato il complesso dei tre famigerati campi di concentramento e sterminio: Auschwitz I, Birkenau (noto anche come Auschwitz II) e Monowitz. Da numerosi anni i campi di sterminio sono stati abilmente convertiti in musei commemorativi che accolgono visitatori di ogni nazionalità.

Dopo due ore di viaggio da Cracovia, l’arrivo mi riservò una prima sorpresa. Non sapevo esattamente cosa aspettarmi, ma dai miei ricordi di scuola immaginavo di trovarmi in un luogo nascosto, poco edificato e dalle sembianze più campestri che cittadine. Invece mi ritrovai dentro una città. Oświęcim per l’appunto. Palazzi e chiese sorgevano intorno alla doppia recinzione in filo spinato.
La gestione del museo era encomiabile: era possibile scegliere la lingua con la quale la guida, con un microfono direttamente collegato alle cuffie di ogni visitatore, avrebbe illustrato il percorso. Il biglietto costava 40 złoty (circa 10 euro).
L’appuntamento per iniziare la visita con la guida italiana era alle 12, davanti al famigerato cancello del campo di Auschwitz I. Riconobbi le immagini del mio libro di storia appena vidi la scritta Arbeit macht frei (il lavoro rende liberi), che sovrastava l’ingresso. Una riproduzione – disse la guida – poiché l’originale è stata rubata.
La seguimmo varcare il cancello e, anche grazie ai suoi racconti, iniziò la mia scoperta del campo, che può essere considerato la capitale dell’Olocausto.

Quello che si prospettò davanti ai miei occhi fu un numero indefinito, ovvero impossibile da contare, di edifici in mattoni rossi architettonicamente simili e ognuno riportante un numero progressivo preceduto dalla parola block. I dormitori. Soltanto alcuni erano aperti al pubblico. All’interno, la gestione del museo aveva esposto i vari oggetti ritrovati nel campo dopo la liberazione. All’ingresso del primo block visitabile, mi trovai di fronte a un pannello simbolicamente pregnante. Riportava infatti il monito di Samtayana, come ad accogliere i visitatori: “Colui che non ricorda la storia è destinato a ripeterla”.
Nelle altre stanze dei block, gli oggetti raccolti permettevano una comprensione maggiore di come poteva essere la vita nel campo. C’erano diversi documenti scritti a mano che contenevano, per lo più, nomi. Poi abiti, casacche a righe, utensili, valigie, occhiali da vista, spazzolini da denti, protesi ortopediche, lucido per le scarpe. Cosa potevano farsene i deportati del lucido per le scarpe in un campo di sterminio? Questa è una delle prove dell’assoluta inconsapevolezza, da parte dei prigionieri, del luogo di destinazione al momento della deportazione.

Tra le prime cose che mi colpirono nelle fasi preliminari della visita, ci fu una grande urna trasparente, colma di ceneri e posizionata sopra una lapide che riportava le date 1940-1945, gli anni di attività del campo. Erano le ceneri umane ritrovate al momento della liberazione del campo, avvenuta il 27 gennaio 1945.
Continuammo la visita all’interno dei block tra cartelli informativi che riportavano statistiche o dati storici, foto dei deportati, modellini ricostruttivi. Ma fu quando mi trovai davanti a una quantità enorme di barattoli che contenevano le sostanze utilizzate per creare il gas letale, che iniziai ad avere una minima percezione dell’enormità di quanto successo: i contenitori vuoti formavano una montagna e bastavano poche quantità per uccidere le persone presenti all’interno della camera a gas. Inoltre, vedevo davanti a me soltanto quelli ritrovati alla fine della guerra. Il numero di quelli utilizzati durante tutta l’attività del campo, verosimilmente, saliva esponenzialmente.
Le ristrettezze della guerra inducevano i tedeschi alla ricerca continua del risparmio. Cercavano quindi costantemente nuove sostanze letali più economiche, di cui però non conoscevano le dosi sufficienti per uccidere. Erano perciò costretti a sperimentarle sui condannati, ottenendo come risultato delle agonie durate fino a due giorni.
La visita proseguì dentro uno dei blocchi più toccanti, quello dove erano conservati i capelli umani. Una montagna di capelli, alcuni intrecciati, buona parte di colore chiaro. A fianco, un esempio di tessuto creato a partire da questi.

Dopo questo block vedemmo il primo edificio strutturalmente diverso: il crematorio. Due stanze, una adibita a camera a gas e subito contigua la stanza con i forni. Per terra erano posizionati alcuni fiori e vicino a questi si trovavano delle foto portate dai parenti delle vittime, come a testimoniare che quelle morti, apparentemente lontane come sbiaditi ricordi storici, erano invece tangibili e vicine. Un ulteriore dettaglio, che testimoniava l’enormità degli eventi, era il colore scurissimo dei muri del crematorio. Il fumo dei forni, nero e dall’odore dolciastro nei racconti dei superstiti, ha colorato le pareti fino ad oggi.
L’ultima parte della visita nel campo di Auschwitz I riguardò il block adibito a tribunale e prigione. In questo edificio venivano giudicati e condannati a morte o alla tortura i deportati che non avevano rispettato una qualche regola del campo. Ovviamente, il tribunale aveva la unica funzione di indurre il rispetto delle regole, mostrando a tutti cosa avvenisse in caso contrario.
La stanza che più mi impressionò fu quella delle minuscole celle dove i deportati rei di qualche colpa venivano mandati a dormire in piedi a gruppi di quattro per cella. Erano della dimensione di una doccia standard, ma fatte di cemento con una piccola apertura alla base che permetteva l’ingresso. Senza aria e senza spazio, viste le precarie condizioni di salute dei prigionieri, spesso qualcuno moriva lì dentro e gli altri presenti dovevano anche sopportare il peso del cadavere.
Al lato del tribunale, un cortile ospitava vari strumenti di tortura e soprattutto il muro della morte.

Davanti a questo venivano fucilati i deportati condannati a morte. Quello visibile oggi non è l’originale ma solo una fedele ricostruzione (i tedeschi prima di fuggire dal campo nel 1945 tentarono di distruggere quanto più possibile, per nascondere i fatti accaduti). Numerosissimi i fiori portati qui dai visitatori come omaggio alle vittime. La guida ci raccontò che nei primi anni di conversione a museo del campo, la terra ai piedi del muro della morte era talmente intrisa di sangue, che i gestori del museo dovettero continuamente aggiungere altra terra, per evitare che il muro sprofondasse.
Il block accanto al tribunale aveva dei pannelli di legno attaccati alle finestre, posizionati per nascondere quanto avveniva al suo interno. Era il laboratorio del medico Mengele, dove egli conduceva i suoi esperimenti utilizzando come cavie i prigionieri e, in particolare, i gemelli. Esempi di esperimenti erano il dissanguamento lento e totale, fino alla morte.
Leggi la seconda parte: visita a Birkenau